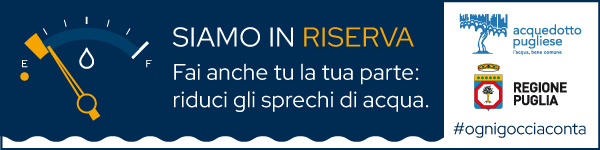Presentato ieri sera, 10 ottobre, nell’Auditorium del Castello, il libro con la traduzione delle Centum Historiae, l’opera più conosciuta di Epifanio Ferdinando. In una sala organizzata al fine di evitare il contatto fisico il dott. Amedeo Elio Distante ha presentato un lavoro durato quasi vent’anni e che ha visto, fino al 2017, il contributo fondamentale della preside Maria Luisa Portulano. Al convegno hanno preso parte il sindaco Toni Matarrelli, il dott. Aldo Patruno dirigente del dipartimento turismo, economia della cultuara e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e il dott. Stefano Lagravinese, Direttore Scientifico e Amministratore Unico di ClinOpsHub, che ha sostenuto e sponsorizzato la pubblicazione del libro.
Presentato ieri sera, 10 ottobre, nell’Auditorium del Castello, il libro con la traduzione delle Centum Historiae, l’opera più conosciuta di Epifanio Ferdinando. In una sala organizzata al fine di evitare il contatto fisico il dott. Amedeo Elio Distante ha presentato un lavoro durato quasi vent’anni e che ha visto, fino al 2017, il contributo fondamentale della preside Maria Luisa Portulano. Al convegno hanno preso parte il sindaco Toni Matarrelli, il dott. Aldo Patruno dirigente del dipartimento turismo, economia della cultuara e valorizzazione del territorio della Regione Puglia e il dott. Stefano Lagravinese, Direttore Scientifico e Amministratore Unico di ClinOpsHub, che ha sostenuto e sponsorizzato la pubblicazione del libro.
Sulla vita di Epifanio Ferdinando e sulla produzione letteraria del grande mesagnese vissuto nel seicento sono intervenuti il prof. Alfredo Musajo Somma, il dott. Gianni Iacovelli e il prof. Alessandro Distante, presidente dell’ISBEM, Istituto scientifico a cui verranno destinati i fondi raccolti dalla vendita dell’importante testo. La serata, moderata dal direttore di QuiMesagne Cosimo Saracino, è stata trasmessa in diretta streaming su facebook e youtube del quotidiano online.
https://youtu.be/MJW92XqQjeU
Approfittando della disponibilità del dott. Amedeo Elio Distante, gli abbiamo rivolto delle domande sul testo appena pubblicato dalla S4M edizioni.
Come ha avuto inizio l’amore per Epifanio Ferdinando?
Circa 25 anni fa un nostro concittadino, mio amico, il prof Enzo Poci, venne da me per coinvolgermi nella traduzione – dal latino in italiano – di alcuni casi medici contenuti in un’opera del 1600, scritta dal medico-filosofo mesagnese Epifanio Ferdinando. E’ così che ha avuto inizio la mia avventura alla scoperta delle Centum Historiae.
Qualche anno dopo, lo stesso Enzo, mentre era a Milano trovò un esemplare originale delle Centum Historiae in una libreria antiquaria ed è così il legame con Epifanio Ferdinando divenne più saldo.
In realtà il mio legame con il Ferdinando risale già alla mia infanzia, quando vivevo nella via a lui dedicata e per recarmi a scuola passavo d’avanti a quella che un tempo è stata la sua dimora, in piazzetta dei Ferdinando.
In questi anni, le opere di Epifanio Ferdinando sono state per me motivo di forte interesse e più mi addentravo nella traduzione di queste opere e più mi rendevo conto di quanto questo uomo, medico, filosofo, seppur con le limitazioni dell’epoca, fosse stato a quei tempi un punto di riferimento in medicina, tanto che due delle sue opere più importanti furono pubblicate a spese dell’Università di Padova, all’epoca tra le più famose d’Europa.
Le Centum Historiae è l’opera più conosciuta di Epifanio Ferdinando, e pur possedendo una certa difficoltà legata alla materia, è scritta seguendo uno schema ricorrente che la rende più comprensibile.
(Res Naturales, Res Non Naturales, Res Praeternaturam, Essentia, Cause, Differentiae, Prognosis, Therapia, etc).
Tratta argomenti che vanno a capite ad calcem, cioè interessano le parti del corpo dalla testa ai piedi. Le Centum Historiae sono la raccolta di cento casi clinici fra i più importanti e significativi occorsi al Ferdinando durante la sua vita professionale.
Può citare un caso?
Ci sono tanti casi interessanti, ad esempio la storia 71 Caso di rara apoplessia, detta rara perché fu raro l’esito fortunato. Un parente del Ferdinando, Felice Riina, all’epoca Camerlengo, preposto dal comune per la riscossione dei tributi e contemporaneamente capo delle guardie comunali, cinquantenne di temperamento caldo e secco (secondo la teoria umorale di allora), con incipiente calvizie e con una corporatura robusta tendente al gracile, girando le campagne per la «stima» delle olive sull’albero, avendo preso pioggia e freddo, si ammalò.
Durante la convalescenza, apprendendo che di notte e in sua assenza, era stata uccisa una delle sue guardie, fu preso da malore ed incorse in questa apoplessia.
Questo termine in greco significa percussione, e come riporta il Dizionario Battaglia: è una sindrome determinata da emorragia cerebrale con perdita di coscienza, sensibilità e abolizione del moto volontario…
Il Ferdinando elenca tra le cause non naturali la costituzione atmosferica caldo-umida, il vento di scirocco, l’abitazione nuova, non ancora asciutta e più esposta perché fuori dalle mura, nonché il mestiere di girovagare per le campagne di giorno e di notte, esponendosi a tutte le intemperie.
Tra le cause naturali valuta come predisponente la costituzione fisica, il temperamento caldo e secco; causa scatenante fu la notizia dell’uccisione del suo amico.
Tra le cause preternaturali mette la malattia (apoplessia), indicandola con i sinonimi quali siderazione, colpo, sprofondamento (descensus scovertum), goccia (gucta paralitica). “Siderazione”, così detta perché si riteneva provocata dall’influsso di una stella maligna [nel dialetto mesagnese esiste l’anatema… cu ti pigghia na coccia celeste].
Descrive l’essenza della malattia localizzata al cervello come dipendente da riduzione, od ostruzione, compressione o restringimento dei ventricoli cerebrali con conseguente perdita delle funzioni principali.
Pone la diagnosi differenziale tra l’apoplessia, l’epilessia, il caro (karos=sonno morboso), la letargia (oblio), l’isteria (praefocatio uteri); si differenzia dall’epilessia perché in questa gli umori sono assorbiti, nell’apoplessia no; dal karo, in quanto in questo è presente la respirazione, mentre nell’apoplessia è difficoltosa; dalla letargia, perché in questa c’è sempre febbre; dall’isterismo, perché le donne sono coscienti e, transacto paroxismo, sciunt omnia enarrare.
Tale patologia è più frequente tra i quaranta e i sessant’anni ed occorre più facilmente nell’autunno per la presenza dello scirocco.
Il primum movens è dato dall’ispessimento e dalla flogosi della pituita, umore catarrale che proviene dal cervello (ghiandola ipofisaria o pituita); tale umore si diffonde nell’organismo e tutti i presidi adottati come gli sternutatori, i salassi, i purganti, le cauterizzazioni, le applicazioni delle sanguisughe, l’induzione del flusso emorroidale, sono volti ad evacuare questo umore corrotto e superfluo.
Lo strappamento dei peli e le torsioni delle parti pudende volevano forse stimolare movimenti riflessi evocando segnali di vitalità per rassicurare i parenti presenti?
La descrizione dei sintomi è valida ancora oggi: “giaceva a letto come morto, ogni sensibilità interna ed esterna era tolta, il movimento abolito, urinava nel letto, perdeva escrementi e spesso era preso da convulsioni dai piedi alla bocca; stimolato non aveva sensibilità, la respirazione non era del tutto mancante pur emettendo bava dalla bocca unitamente ad un respiro stertoroso”. La prognosi era pertanto riservata.
L’indicazione terapeutica si avvaleva di: dieta, chirurgia e farmacia.
La dieta riguardava l’ambiente esterno, le funzioni vitali e la dieta vera e propria, per cui si riscaldò l’aria dentro casa, si sollecitò l’intestino con clisteri ed era alimentato con una dieta leggera.
La chirurgia si avvaleva dell’uso delle ventose, scarificate, e delle cauterizzazioni sul capo dell’ammalato, nonché dei salassi ripetuti.
La farmacia consisteva in lassativi e purganti, applicazioni di polveri sternutatorie alle narici, nel praticare unzioni alla testa ed alla nuca e nella somministrazione per via orale di una quintessenza preparata dallo stesso Ferdinando.
Oltre al curare, una volta ristabilito il paziente, si doveva provvedere alla profilassi delle recidive, riscaldando l’ambiente domestico, evitando il freddo e l’umido, seguendo una dieta leggera ed evitando le emozioni.
Probabilmente non si trattò di vera apoplessia: poco probabile che fosse un coma metabolico o un TIA (della durata massima di ventiquattro ore); forse era un RIND (deficit neurologico ischemico reversibile che può durare fino a tre settimane), oppure uno spasmo ischemico prolungato con edema diffuso, o ancora un trombo non grande e con edema generalizzato che per spontanea fibrinolisi si era dissolto; cioè il malato era ritornato allo stato primitivo di saluto senza mostrare alcun reliquato.
Ci sono state difficoltà particolari?
Voglio raccontarvene una a proposito dei nervi cranici.
In Galeno le paia dei nervi cranici erano sette, come anche in Mondino de’ Leuzzi, ma non per Bartolomeo Eustachio da Sanseverino Marche, le cui tavole ne elencavano dieci.
A proposito dell’innervazione dei visceri interni, il Ferdinando parla di VI paio, che per me, senza verificare, secondo l’attuale nomenclatura è il Nervo abducente (n. indignatorio), ed invece secondo la verifica della classificazione di Galeno era il Nervo vago (vagabondo), come scrive Lancisi nelle note alla tavola XVIII dell’Eustachio, che lo comprende nell’ottavo paio: olim sextum & vagum nuncupatum.
Ma il Ferdinando avrebbe potuto conoscere le tavole di Eustachio perché alla morte dell’anatomico egli aveva otto anni; ma non poteva conoscere Willis, perché quando il nostro morì il Villisio era diciottenne e non ancora medico.
Il motivo è presto spiegato: le tavole di Eustachio furono pubblicate centocinquantanni dopo la sua morte per interessamento di Giovanni Maria Lancisi e di papa Clemente XI. Questi, venuti a sapere che il marchigiano le aveva affidate al medico Matteo Pini, suo allievo e concittadino, interessarono il vescovo della curia di Sanseverino Marche per cercare presso gli eredi del Pini: trovarono una pronipote, la vedova Rossi, e le tavole che Lancisi pubblicò e commentò.
Il Villisio non poteva sapere per lo stesso motivo di cui sopra che Eustachio aveva catalogato anche il Nervo accessorio e quindi lo descrisse riscoprendolo. E tuttora è chiamato accessorio di Willis.
Una piccola curiosità: l’unico figlio di Bartolomeo Eustachio aveva il nome di Ferdinando. Attualmente, per merito del polacco Samuel Thomas von Sommerring (1788), è accettata la catalogazione di dodici nervi cranici, dove il vago è il decimo paio. Quindi la storia della medicina è fatta talora di situazioni complicate e per districarle ci vuole attenzione e verifica.